Monthly Archives: Dicembre 2016

l' ultimo nastrino rosso
Un racconto di Fuani Marino
Numero di battute: 2484
Letizia s’iscrisse a un corso su come decorare l’albero di Natale. Lo fece senza pensarci troppo, accodandosi svogliatamente a un gruppo di mamme della scuola dei suoi figli, per poi ritrovarsi seduta nella saletta di un multistore in centro, spalla a spalla con altre signore che s’interrogavano su quanto dovessero essere grandi gli addobbi lungo le estremità. Esisteva un vero e proprio protocollo da seguire. L’equazione dell’albero perfetto vuole che l’albero, se vero, venga scelto con attenzione fra le numerose varietà – meglio un douglas o un balsam fir? – e, quando artificiale, sia dalla forma armonica e con folti rami ad accogliere i lustrini.
Una volta varcata la soglia di casa, tipico interno borghese caldo e ben arredato, Letizia trovò i bambini che cenavano in pigiama imboccati a turno da Rosemary, la colf filippina che viveva con loro.
«Questo Natale però era diverso.»
Malgrado fosse già in pantofole, costrinse suo marito a rimettersi le scarpe e a scendere in cantina per prendere il necessario: l’indomani avrebbe avuto inizio l’allestimento, era quasi fine novembre, d’altronde. Tanta premura non veniva dal timore di dimenticare qualche passaggio fra quelli appresi al corso, quanto dalla speranza che l’illuminarsi ritmico delle lucine venisse a rassicurarla anche quest’anno. Le avrebbe guardate scintillare dal divano o, nel buio della casa addormentata, quando si aggirava fra le stanze come un animale notturno in preda alla sua insonnia.
Questo Natale però era diverso. Letizia avvertiva più stanchezza che eccitazione, noia nello scegliere i regali; le festività le risultavano faticose, e la scuola sarebbe restata chiusa per quasi venti giorni. Il calendario dell’avvento, con le sue piccole caselle da aprire, le trasmetteva ansia, era come se presagisse un pericolo, qualcosa di sinistro che partiva da lei per spingersi all’esterno e propagarsi a quel periodo dall’apparenza festosa.
La fase di decorazione durò un paio di giorni, lei ritta sullo scaletto per raggiungere la cima dei due metri e ottanta centimetri, con i cori natalizi in sottofondo, e i bambini che volevano aiutarla ad appendere palle, casette e pigne dorate, ma che riuscivano solo a infastidirla. Si era ormai fatta strada dentro di lei la sensazione che fare quell’albero fosse perfettamente inutile, e che lei, tutta presa dallo scegliere la decorazione giusta, non fosse altro che un’immagine stereotipata, niente di molto diverso dalla caricatura di se stessa, pensò legando l’ultimo nastrino rosso.

Fuani Marino (1980) è nata a Napoli, dove vive e lavora. Giornalista, ha scritto per Corriere del Mezzogiorno, Flash Art, The Towner. Dopo aver frequentato corsi della Scuola Holden e della Scuola del Libro, ha appena terminato di scrivere il suo primo romanzo.

cose che servono sempre
Un racconto di Nicola H. Cosentino
Numero di battute: 2477
Sapevo di trovarlo lì. Altre due volte, negli ultimi mesi, mi aveva scritto Sto pensando. Mi raggiungi? e poi l’indirizzo preciso, via Casale Redicicoli, 501. L’Ikea della Bufalotta. Sedeva in punta alla chaise-longue di un divano Dagstorp e attendeva, le mani ad amen e le gambe larghe, l’ora di cena. Poi prendeva due autobus e tornava a casa. Giustificava il viaggio con l’acquisto di una lampadina, quattro piatti, un tappeto per il bagno. Lei non si scomponeva: «Sono cose che servono sempre›». L’ultima volta che mi costrinse a raggiungerlo fino a Porta di Roma per guardarlo riflettere, Vincenzo aveva ai piedi le scarpe running dei giorni di ribellione. Indossarle era il suo bengala di libertà: le calzava con fierezza, noncurante della consunzione craterica sulla parte gommata, nei giorni in cui perdeva un lavoro, viaggiava da solo o litigava con Nicole. Ogni tanto glielo facevo notare. «Hai queste vecchie scarpe» dicevo, e lui rispondeva sempre: «Belle, no? Le mie preferite».
Quel giorno non dissi niente. Fuori pioveva forte, e raggiungerlo mi aveva innervosito. Mi limitai a sedergli accanto e fissare un televisore spento, incastrato sul cartongesso perlato di quel salotto posticcio, lo stesso che aveva riprodotto un anno e mezzo prima nei quaranta mq in cui viveva con Nicole. Era come pensare a casa sua, ma in un universo irreale, circondato da un raccordo di borsoni gialli, coppie consultanti mappe e dépliant con la matita tesa in avanti come il bompresso di un veliero.
«Sedeva in punta alla chaise-longue
di un divano Dagstorp e attendeva.»
Anche tra i suoi piedi c’era uno di quei borsoni: era pieno di candele alla cannella, le preferite di Nicole, e una grossa lampada a forma di cuore. Vincenzo la scavalcò e raggiunse il confine ideale del soggiorno bianchissimo, il loro, per entrare nel mondo accanto, una stanza da studenti fricchettoni piena di arancioni cozzanti e zebrati perfetti, e mobili verde acqua dalle striature ruvide, amatoriali. Un mondo fatto-male-apposta, in eterna ridefinizione, come piaceva a lui. Fece piccoli saltelli da una parte all’altra, dal parquet di mogano alla moquette azzurra, poi si fermò a cavallo del confine, con le gambe ad arco tra le parti tipo Colosso di Rodi. Quando finì, tornò accanto a me.
«Non sono d’accordo con quello che stai pensando» gli dissi. «Che le case è più bello sceglierle che abitarle.»
Lui non rispose.
Non so a che ora uscimmo, non me lo ricordo. Nella mia testa siamo rimasti lì, nel cuore trasparente di quel mondo nuovo, a sopportare immobili la notte.

Nicola H. Cosentino (1991) è nato a Praia a Mare (CS) e vive tra Roma e Cosenza. Giornalista pubblicista, ha collaborato per anni con il Quotidiano del Sud. Dal 2014 cura la pagina culturale del blog Venti, di cui è cofondatore, e organizza il festival di cinema indipendente Brevi d’Autore. Ha pubblicato alcuni racconti su Colla, scrive di letteratura su minima&moralia. Il suo primo romanzo è Cristina d’ingiusta bellezza (Rubbettino Editore 2016).
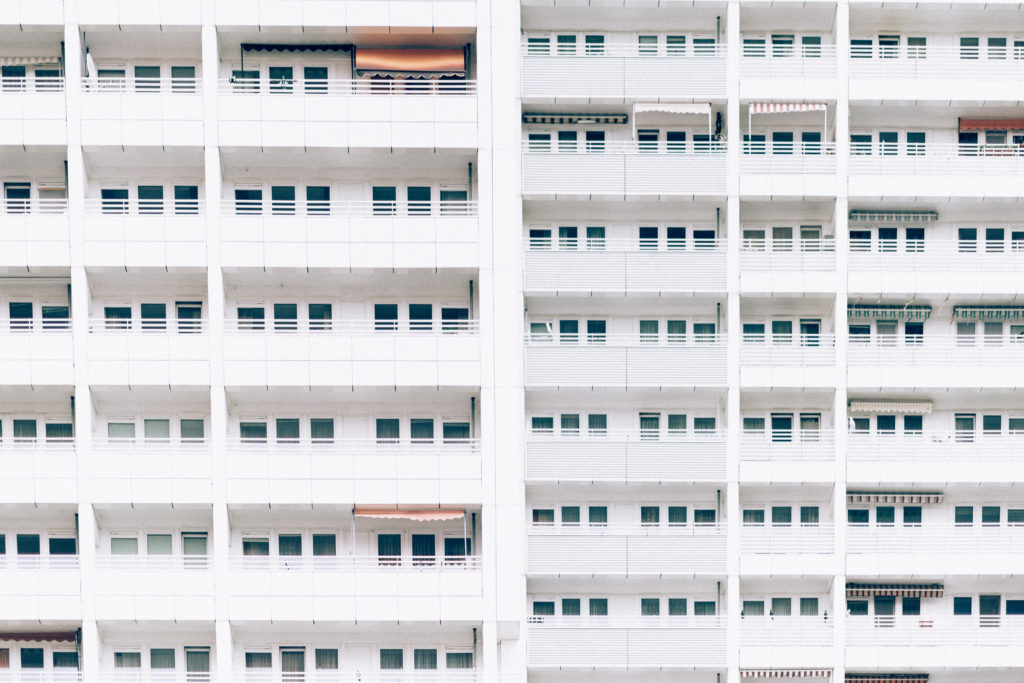
la veranda
Un racconto di Gabriele Di Fronzo
Numero di battute: 2500
Dopo qualche giorno che l’uomo se n’è andato via di casa, non sappiamo chi delle due sia quella rigorosa e chi quella conciliante, chi è morbida e chi scorbutica anche senza ragioni. Eppure non c’è approssimazione, la nostra prodezza è femminile, svola tra i marmi della cucina come spezie seccate al piccolo vento di un amore settembrino. So che prima o dopo lei ne sentirà il bisogno fino a domandargli di tornare, ma per ora lui è chissà dove a cercare un appartamento vuoto. Non c’entra nessun diverbio, è lei che ha deciso che avendo me può fare a meno dell’uomo. Per questo passiamo i primi giorni a dire ogni male che si merita, che lei ha smesso di amarlo, e che abbiamo fatto bene a mandarlo via.
La tenevo per mano, ci facevamo spazio tra i mobili della cucina e attraversando l’ingresso la conducevo verso il finestrone rivettato del salone. Giravamo lente su noi stesse. A chi ci avesse guardate, avremmo dato l’idea di donne a una festa di compleanno antica.
«Si tratta di dimenticare
che esiste altro
oltre noi.»
Nessun accordo semplice si è potuto avanzare in quella casa, da parte di chiunque delle due. Meno male c’era la preghiera. Si tratta di dimenticare che esiste altro oltre noi. Parliamo dell’uomo come corpo in mare sparito. «Oggi non voglio parlare di lui», ha detto anche stamani la donna. Lo ripete sempre, io accetto le sue bugie perché bisogna accettare che chi sta male menta. So, però, che ogni tanto si vedono, quando io esco e dico che starò via per un paio d’ore. Capita quando ho delle visite mediche o vado in chiesa. La donna chiama l’uomo al telefono e questo si sbriga ad arrivare. Non ha più le chiavi: gli aprirà lei, già senza la biancheria per quanto a lui piacesse toglierle il reggiseno, le calze e le mutandine, ma qui prevale l’esigenza ad altre manie, chiuderà la porta di casa con una doppia mandata e se lo porterà a letto. Che poi, se io dovessi tornare, non se ne farebbero nulla di una o due mandate: busserei e chissà come lei si disferebbe dell’uomo nel letto. Ma, visto che temo che non se ne disferebbe e anzi lo prenderebbe a pretesto per farlo ritornare a casa, se le dico che sto fuori un paio d’ore, rincaso perlomeno dopo tre ore.
Quando ieri mattina, dopo la messa, sono tornata a casa, un carabiniere mi ha fermata davanti al portone del palazzo. Non mi voleva lasciar entrare, finché non gli ho indicato sul citofono il cognome della persona da cui ero attesa. Ha fatto uno sguardo atroce. Nell'androne c’erano alcuni condomini che, parlando della nostra veranda, la definivano bella e alta.

Gabriele Di Fronzo (1984) è nato a Torino. Collabora con L'Indice dei Libri del Mese e Rivista Studio. Ha pubblicato racconti su Nuovi Argomenti e Linus. Il grande animale (nottetempo 2016, Premio Augusta, Premio Volponi Opera Prima, Finalista Premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante) è il suo primo romanzo. (Foto di Stefano Saporito.)


Commenti recenti