Monthly Archives: Novembre 2017

il punto più alto
Un racconto di Alessandra Minervini
Numero di battute: 2378
Ci chiamano Sale e Pepe. Abbiamo diciotto anni. Io ho la testa che sputa forfora, Pepe ha un neo massiccio sulla guancia. È il mio migliore amico. Non ha la barca. Possiede altri benefit. Pepe è bravo a scuola. Io cesso. Se i prof scocciano, li invito in barca. Chi resiste? E poi c’è sua madre che è una bona mondiale. Un giorno diventerà mia.
La sera del diploma: festa in villa da me. Siamo organizzati così. Sale mette i dischi. Pepe dice quali. Funky, afro, una cosa che spinge. Pepe sa, ha groove. Sale ha i contatti. Cento invitati. Mi viene da dire: sballo!, non rende l’idea. Ci sono i soliti della scuola, i diplomati dell’anno scorso, gli amici del tennis, del calcetto, del campus estivo, quelli degli scacchi, la classe del Conservatorio.
Nel pomeriggio vado da Pepe. Onoro con gli occhi le tette della madre: santissime, sanno di ciambella. Lei mi chiama manidimerda: ogni volta che la vedo mi cade qualcosa. Mi imbarazzo. Pepe: andiamo in un posto e porta la musica.
«Amo tua madre, confesso.»
Ci vogliono quarantacinque minuti a piedi e un poco di affanno toracico per raggiungerlo. La strada è tutta in salita. Una rarità: è una zona piuttosto piatta. Appena si scavalla il paese, spunta la chiesetta bianca. Il punto più alto. Il mare si conficca sulle distese di ulivi senza gradi di separazione tra acqua terra e aria.
Quando una cosa non esiste, diventa l’unica cosa da vedere.
Amo tua madre, confesso. E lui: sei pazzo. Va bene, gli dico. Come quando in salumeria abbondano i grammi del cotto: “Lascio?” E rispondo: “Va bene”.
Poi ripeto: amo tua madre, è mia. Lui sostiene lo sguardo, alza il volume. La musica si scatena. Muovo i fianchi, ballo, non capisco il testo. A cosa servono le parole quando c’è un suono che sale.
È qui che ti uccido, gli faccio. Il tramonto devasta la chiesetta, sulla croce s’infilza l’arancio. L’ingresso è spalancato. Le sedute sono abbattute, sull’altare è cresciuto un ulivo, le radici ci contemplano come fedeli incantati. La musica sconosciuta è l’unica cosa che vibra sul suo corpo. Le ferite in mezzo alla gola si muovono a tempo. Lecco un dito di San Michele su cui è finito del sangue. Sa di liquirizia.
Sulla strada del ritorno mi sento come gli ulivi che esplodono sputando fuori le vecchie radici. Invecchiando, invece di abbassarsi, le foglie sui rami si piegano verso il cielo, toccano il punto più alto. Eppure, non sono mai stato un albero.

Alessandra Minervini (1978) è nata a Bari, dove ora vive. Suoi racconti sono apparsi su alcune riviste, tra cui Colla, EFFE, Cadillac. Ha pubblicato il romanzo Overlove
(LiberAria, 2016). Organizza e tiene corsi di scrittura.

l’ordine degli universi
Un racconto di Federico Di Gregorio
Numero di battute: 2481
In Turchia chiamano il Mar Mediterraneo “Ak Deniz”, mare bianco. Marco lo ascolta dire in televisione mentre incarta un enorme uovo di cioccolata, con dentro un rossetto scuro, perché Denise ama i trucchi scuri, e ama le uova di cioccolata.
La scuola è finita da venti minuti. Si sentono i motorini volare giù da via Castiglione. Il Gonzo è senza mutande, non le ha messe perché ha caldo - dice -, ma forse è per festeggiare l’evento che stavolta non dovrà ripetere l’anno.
«Cazzo, dài! Scendi o salgo? Salgo?»
Non ha il senso della misura.
Il Gonzo e Marco sono compagni di banco. L’anno scorso si sono fatti bocciare per aver tentato di dare fuoco all’auto della preside Grisaldi, nel suo giardino.
«Cazzo, dài! Scendo o salgo? Salgo?»
«Ho visto un uovo di cioccolata!» dice il Gonzo. «Marco… cazzo… ho visto un uovo di cioccolata!» Il Gonzo urla e si mette le mani tra i capelli ricci unti e inizia a ridere sguaiatamente grattandosi la testa umida di sudore. «Cazzo… Marco… ho visto un uovo di cioccolata, a giugno!»
Una vespa piccola gli gira attorno. Marco la vede dall’angoletto della finestra ma non gli dice nulla, all’amico senza mutande.
«Denise è la ragazza per me, invece. Lo sai?» dice il Gonzo.
Marco sta aggiustando il fiocco rosso. Lo sta sistemando facendo attenzione che la curva di rosso a destra sia poco più grande della curva a sinistra, pretendendo di centrare l’armonia.
Ora soffia contro la seta per scacciare la polvere.
Scuote la testa. Il Gonzo da fuori lo fissa.
Marco prende un pennarello. La carta che copre l’uovo è bianca e stropicciata, così ci scrive una cosa: “Ak Deniz”, mare bianco.
Lui non ha mai creduto alla strana teoria dell’ordine degli universi, spuntata fuori da un romanzo che ha appena letto: dice che tutto scorre con una logica, sensata, mica come il loro amore.
«Ma uno come te, si può innamorare di una così?» dice il Gonzo.
Marco prende l’uovo, lo incastra sotto al braccio. Apre il portone.
«Marco, ti sei fottuto il cervello!»
«Mi dai respiro?»
«Tu vai a casa della preside Grisaldi, a giugno, a dare un uovo di cioccolata alla figlia, che ci esci e la madre che ti odia nemmeno lo sa?»
La vespa ascolta. Entra nella tasca del Gonzo.
Marco fa finta di nulla, va verso lo scooter e prende il casco.
«Andiamo?» chiede Marco saltando in sella.
Il Gonzo scuote la pancia con le mani. Lo fa abitualmente.
La vespa così infila il pungiglione e lo ritrae.
Il Gonzo corre.
Marco ora parte alla volta di Denise. Perché a lui non importa nulla della stramba teoria dell’ordine degli universi.

Federico Di Gregorio è nato nel 1985. Nel luglio 2017 ha pubblicato il romanzo breve Le differenze (Delos Digital).

quella cosa
Un racconto di Marta Santomauro
Numero di battute: 2497
Proprio in quel momento, lei gli disse quella cosa.
Lui fece finta di non sentirla. Scoppiò a ridere.
Lei neanche si arrabbiò. Erano troppo fatti per prendersi sul serio e poi quella era – a detta di tutti – la festa del secolo.
La stanza trasudava alcol e ganja. Anche i loro capelli puzzavano di fumo nonostante le parrucche e i litri di lacca.
Vestiti come sarai tra vent’anni.
Era questo il motivo per cui lei gli aveva detto quella cosa.
Tutti gli altri sembravano avere le idee chiare, come se avessero già messo in conto marmocchi, avvocati, porte del bagno sbattute forte e cenoni della vigilia con le famiglie riunite.
Anna era una hippie con i capelli grigi intrecciati sulla nuca, decisamente troppo bella per rispettare il tema: si era scordata le rughe. Mirko era incaricato dell’accoglienza: con i capelli imbiancati di talco sotto il berretto rosso di McDonald’s rispondeva al citofono, raccoglieva i cappotti e li buttava sul letto di fianco a Linda e Giacomo in procinto di fare un bambino in ritardo (o in anticipo?), improvvisava presentazioni tra nuove Loredana Berté e non più giovani fattorini di Deliveroo.
Un’altra coppia limonava sul divano mischiando il completo gessato di lui con la tuta da meccanico dell’altro lui.
Bevevano vino rosso impreziosito, passando di mano in mano quella bottiglia magica con lunghi sorsi a canna.
Il rumore di un bicchiere fracassato tra le mattonelle e il tappeto persiano fece prima girare e poi ridere tutti. Il tizio scalzo che stava camminando sui vetri, invece, sembrò non accorgersi di niente.
«Erano troppo fatti per prendersi sul serio.»
A lei tornò di nuovo in mente quella cosa. Un po’ tremolante, ma sempre intatta.
Pensò di ridirla e lo fece.
La sentì rimbalzare nell’aria, facendo anche un po’ di eco.
Si sentì molto sola.
Lui girò l’obiettivo della fotocamera.
«Facciamoci una foto» disse impastando la voce con dell’altro gin tonic. Arricciò le labbra a culo di gallina guardando il flash.
Lei invece spostò lo sguardo lontano, da un’altra parte. Alzò il mento e si girò proprio verso dove sapeva che l’avrebbe portata quella cosa.
Lui le arrotolò un braccio intorno al collo, incastrando le dita in mezzo ai colori sgargianti della giungla che c’era sul suo foulard di seta. Infilò gli occhiali da sole nel collo della camicia freak di cui era molto orgoglioso, sistemò il ciuffo ingellato per liberare un occhio. Il pappagallo stampato sul collo di lei sorrideva nell’obiettivo.
Dentro quel click della Polaroid si fermò tutto.
Ma per quella notte, loro erano ancora giovani e scemi.

Marta Santomauro (1984) è nata a Milano, ha studiato Design della Comunicazione e lavora come libraia alla Gogol and Company di Milano. Nel 2013 è stata tra i vincitori del premio letterario Subway. Alcuni suoi racconti sono apparsi sulle riviste Scrittori Precari, Colla, Cadillac, Foro.

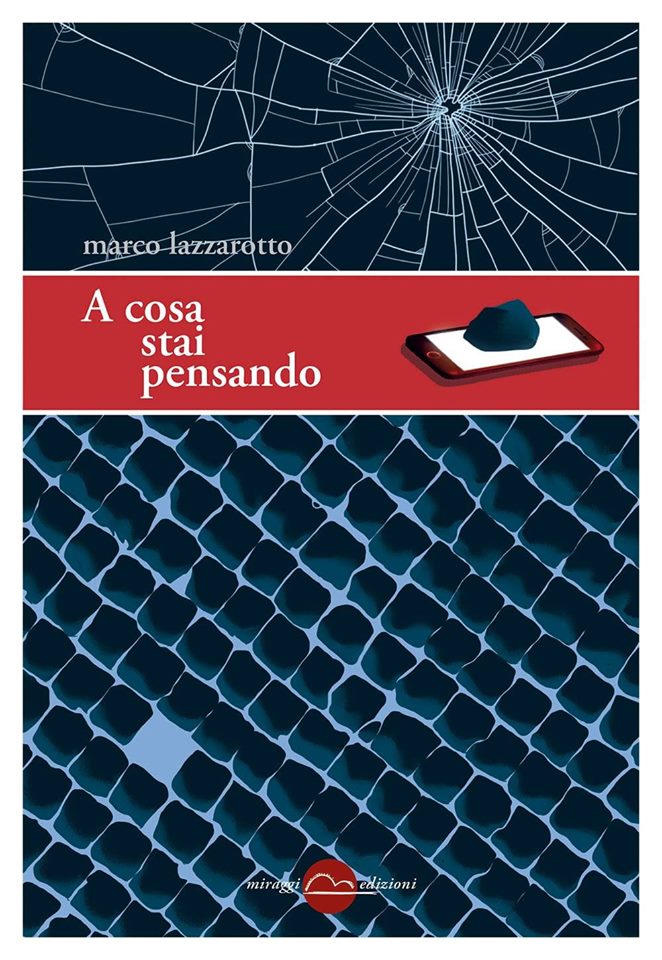


Commenti recenti