Monthly Archives: Gennaio 2023

da quanto...
Un racconto di Alex Guerra
Numero di battute: 1942
Da quanto non parliamo, veramente, come quando questo salotto non esisteva ancora? Come quando lo costruivamo, lo dipingevamo, l'arredavamo a parole? Come quando al posto del divano che ti piace tanto usavamo un materasso buttato direttamente per terra. Ce le dicevamo sopra là, ricordi? E tra una grattata di intonaco, o l'assemblaggio di un mobile, spiavamo fuori dalla finestra le famiglie con i passeggini e ci immedesimavamo nel ruolo di genitori.
Dopo che avevamo fatto l'amore sopra il materasso, la fronte adagiata sull'incavo della tua nuca, il mio braccio che ti cingeva la vita, ti suggerivo nomi per un possibile, mai arrivato, figlio: Juri, Gregorio, Mattia se fosse stato un maschietto; Elena, Aurora, Lionora nel caso di una femminuccia. E tu annuivi, docile.
In quella posizione ti ho annunciato la mia nomina ad assistente del Direttore Marketing e che in casa i soldi non sarebbero più mancati.
Poi costruimmo, dipingemmo, arredammo.
Come hai sempre voluto tu. Credevi che io volessi questo pugno nell'occhio di sofà, avrai creduto che il colore mi piacesse, e questa sfilza di libri presi in stock all'Ikea insieme alla libreria. E io ho sempre annuito docilmente ad ogni tua fantasticheria. Come quando giocavamo alla bella famigliola, tu giocavi e io ti assecondavo, guardando fuori dalla finestra di questo salotto che ancora non avevi fatto a tua immagine e somiglianza. Io in realtà guardavo le donne e gli uomini in camicia e giacca che salivano su Bmw e Mercedes. Ma allora come ora, ho bisogno anche dei tuoi abbracci.
Come quelli da dietro, dopo che avevamo fatto l'amore.
Per questo ti risposi che lo stipendio da assistente Direttore Marketing era buono ma volevo cercarmi lo stesso un lavoretto – visto che avevo una laurea tanto valeva farla fruttare, no? – giusto finché non ci sistemavamo. Non potevo confessarlo allora e non ha senso ammetterlo adesso, che non ricordo neanche più da quanto non parliamo veramente.

Alex Guerra è nato nel 1994. Abita a Breganze, in provincia di Vicenza. Diplomato in Elettronica e telecomunicazioni, lavora come operaio in una ditta di imballaggi flessibili. Tra un turno e l’altro cerca di laurearsi in Lettere moderne all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Suoi racconti sono usciti sulle riviste Blam e Spore.
matteo
di pascale
Matteo di Pascale (1987) è scrittore e designer. È autore del Manuale di sopravvivenza per UX designer (Hoepli, 2019) e degli strumenti per la creatività applicata intùiti, Fabula, Fabula Kids, Cicero, Edito e Bad (Sefirot Editore), che hanno venduto oltre 100.000 copie in tutto il mondo.
Ha pubblicato i romanzi La lezione di Milano (Blonk Editore), Il piano inclinato (Las Vegas Edizioni) e Mario (Sefirot). Scrive una newsletter settimanale, il Bollettino creativo di Sefirot, letta da oltre 10.000 persone.
yvonne
campedel
Yvonne Campedel (Recanati, 1992) lavora come illustratrice e grafica pubblicitaria dal 2016. Ha illustrato libri per Bloomsbury Publishing, Oxford press, Clementoni, Nomos edizioni e il Battello a Vapore. Ha scritto e illustrato l’albo Il viaggiatore immaginario (KM edizioni 2021).
Il suo primo romanzo per l'infanzia è Nilde Sterminio e il mistero della villa abbandonata (il Battello a Vapore 2023), vincitore del Premio il Battello a Vapore 2022.

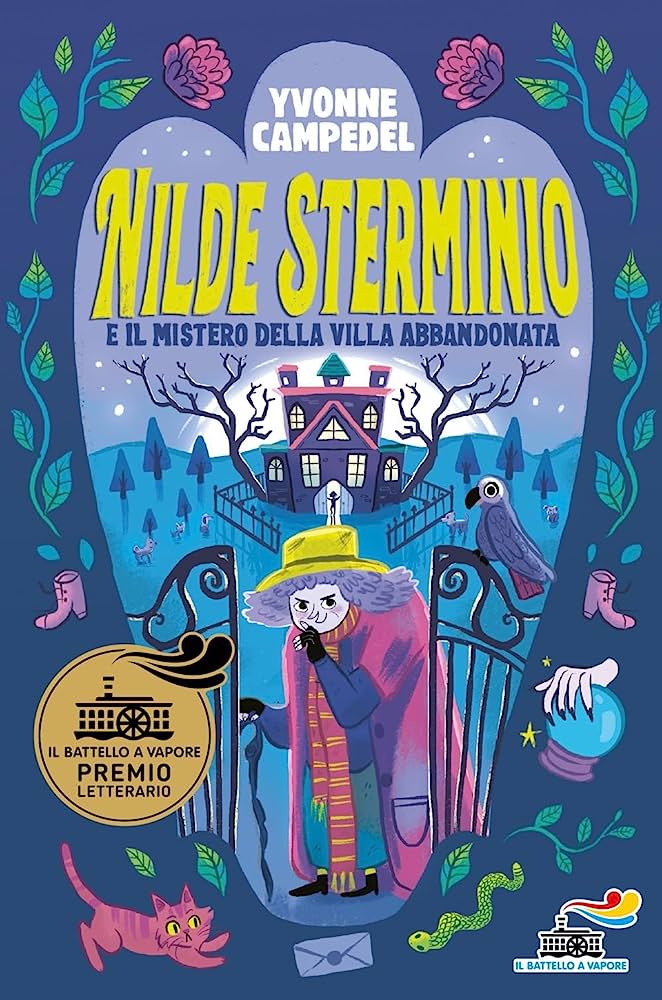













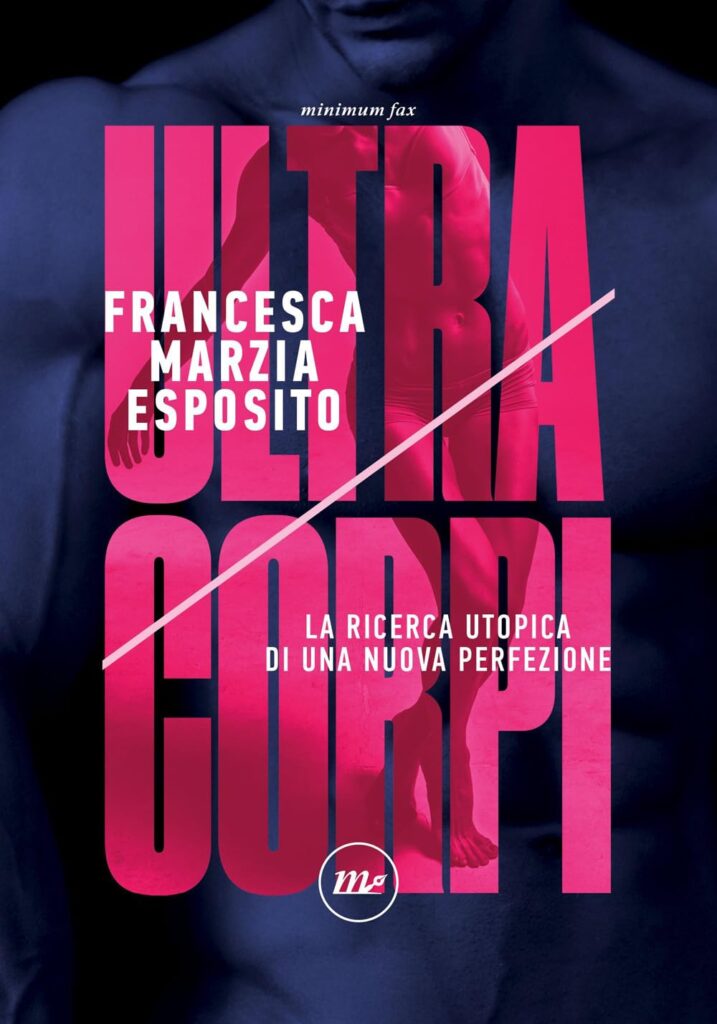








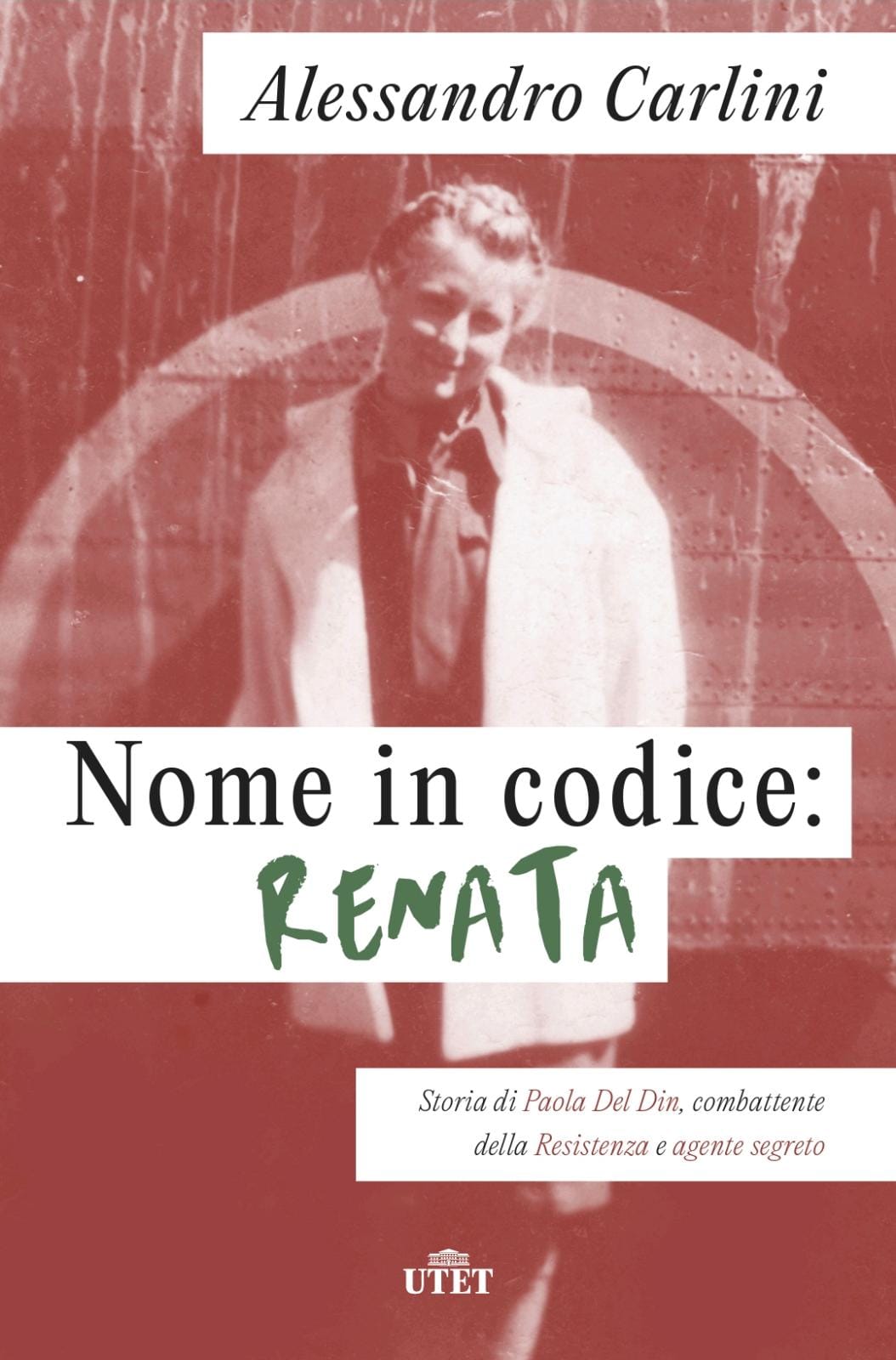


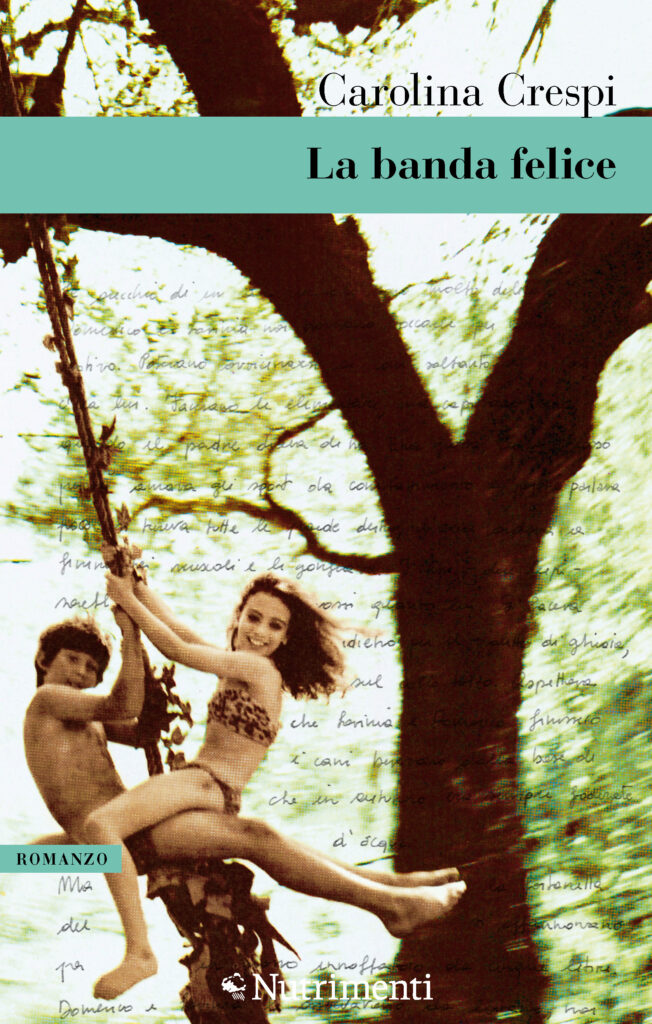

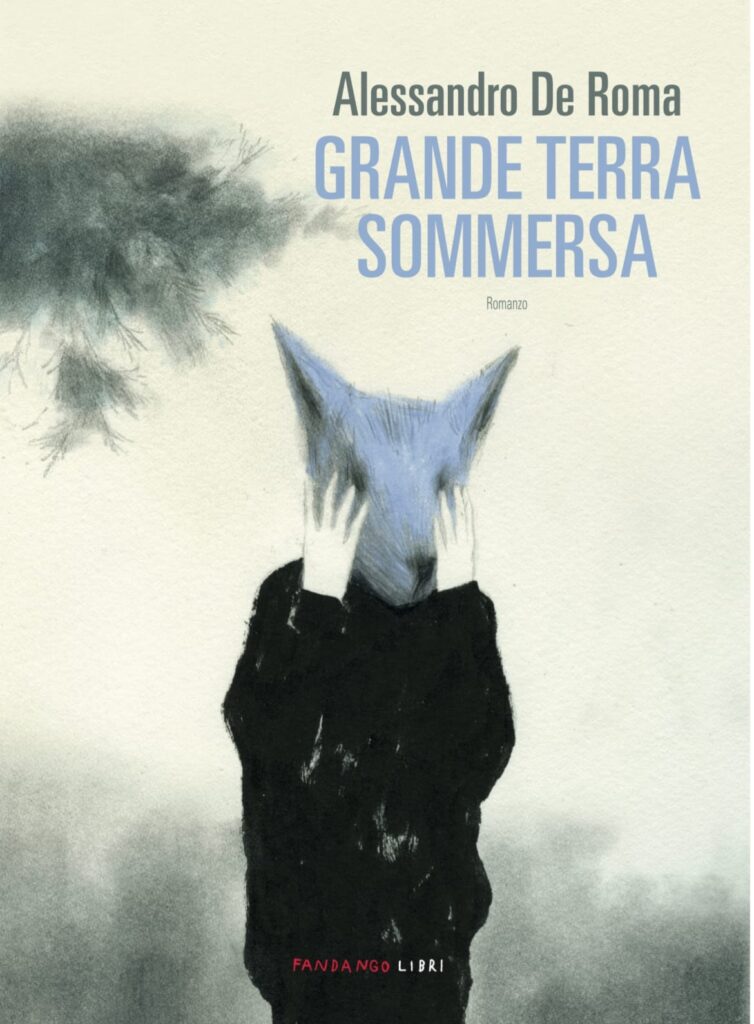




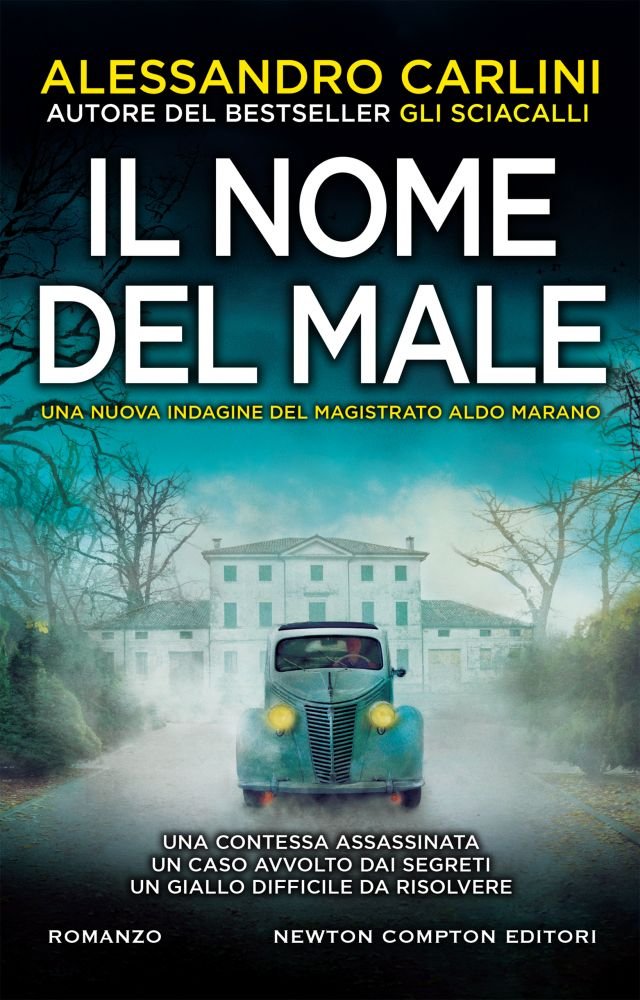

















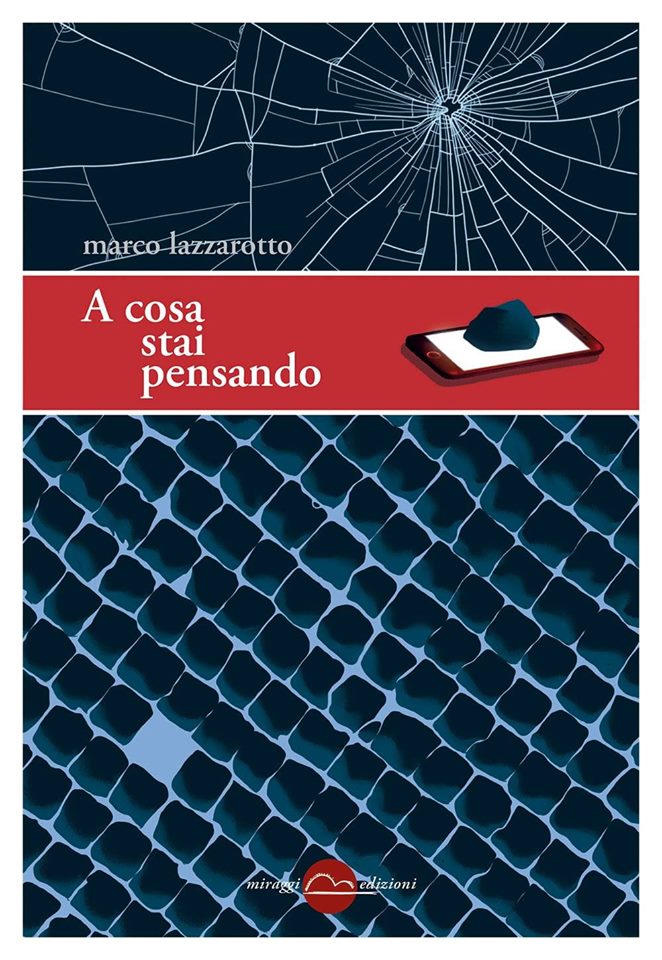


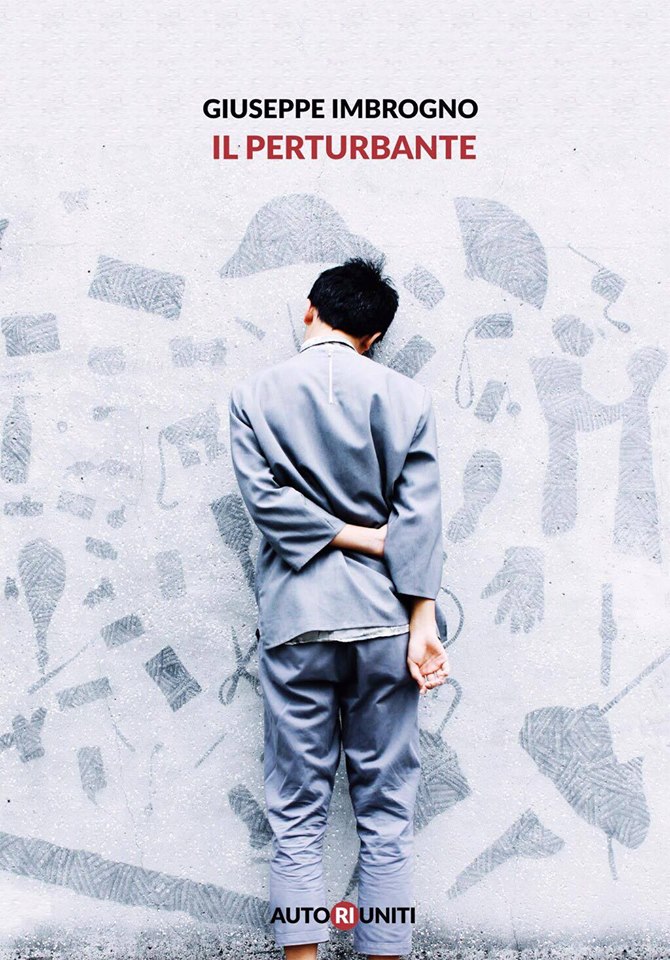
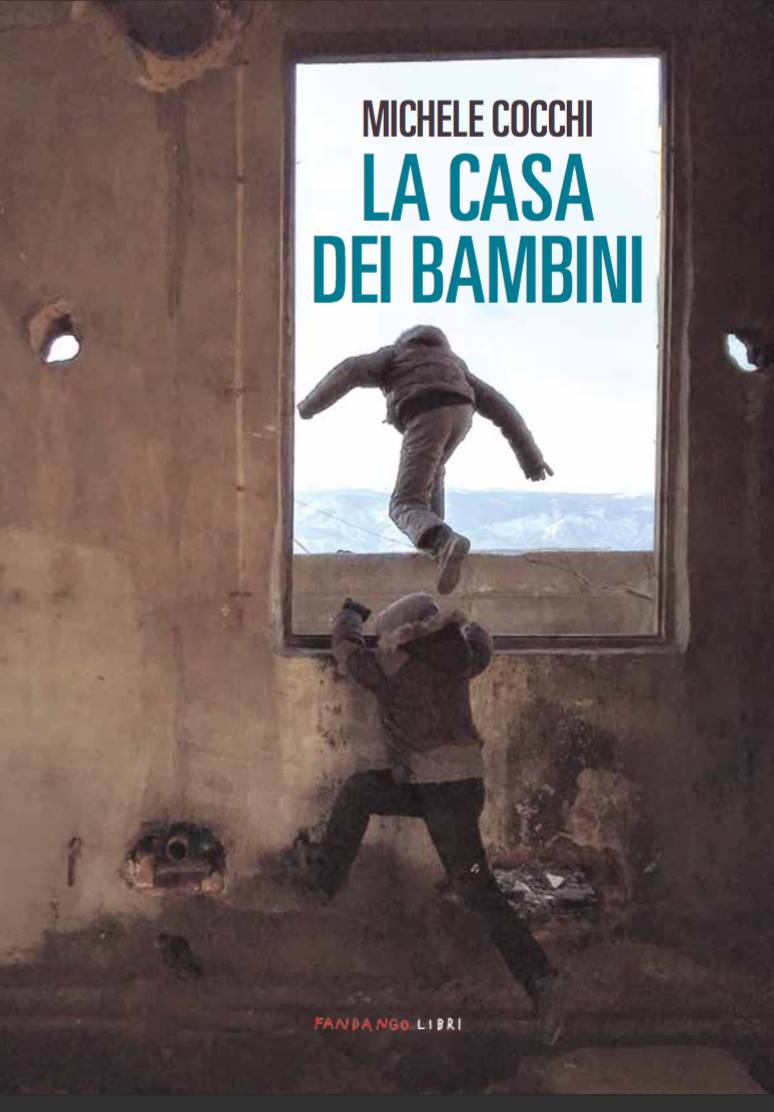

Commenti recenti