Monthly Archives: Luglio 2023

la questione del gotico
maniscalco stanco
Un racconto di Simone Massara
Numero di battute: 2457
Un maniscalco gotico, stanco d’esser maniscalco, leggeva un romanzo seduto in poltrona presso la finestra. Non prestava attenzione al libro. Sul tavolo al suo fianco, un bicchiere mezzo vuoto era illuminato dai chiari raggi solari fluttuanti attraverso il vetro della finestra. Gli attrezzi arrugginiti riposavano sul bancone, in fondo, e il caminetto ardeva dolce, languido nelle sue stesse braci.
Ma il maniscalco attorcigliava le meningi, come le gotiche edere miniate nei codici, attorno a una domanda. La domanda gli pareva sciocca. Eppure al tempo stesso così pregnante. Lo assillava quando la evitava; una zanzara, che torna a ronzare nell’orecchio, gli occhi appena chiusi, in una notte d’estate. Non trovava risposta, scacciava la domanda, e questa ritornava. Gli occhi inciampavano sul romanzo, e il bicchiere era sul tavolino, gli attrezzi abbandonati lì, in fondo alla sala, il caminetto ardente all’angolo, le ombre sul legno del pavimento parevano scricchiolare, e la domanda era: “Cosa fa un maniscalco?”.
Tremava tutto. “Cosa fa un maniscalco? E, per di più, se è anche gotico? Cosa lavora? Che attrezzi usa? Chi va dal maniscalco?”
«Cosa fa un maniscalco?»
Perché, a dirla tutta, forse il nostro maniscalco gotico, stanco della sua vita da maniscalco, questa parola designante il suo mestiere la conosceva solo per sentito dire, per le fiabe, i vecchi libri, le leggende… Lui stava lì seduto a leggere, ed era un maniscalco. Immobile, inamovibile era; mentre la realtà scalciava.
Fuori brillava il sole, una luce ineluttabile (impossibile sbagliarsi su quanto fosse reale quella luce!), eppure lui era sempre lì e faceva sempre di mestiere il maniscalco. Era mai possibile una cosa del genere? E come ci era arrivato, poi, a fare il maniscalco? C’erano degli studi? Aveva un diploma da maniscalco? Un certificato, una patente, un riconoscimento qualsiasi della gilda dei maniscalchi? E tutto questo ripetere quella parola, lunga e strana, dal suono spezzato, non la rendeva assurda, allucinante?
Allucinato, sentiva il suo corpo in migliaia di particelle immerse nel viscoso elemento di un tempo bloccato in un presente eterno, paradossale, ed era spaventato oltre l’inverosimile, mentre manteneva il suo atteggiamento discreto, lì accanto la finestra, col suo romanzo in grembo, e dentro un tremendo terremoto lo sventrava. Il nostro maniscalco. Neanche una lacrima. Ma tutto quello spavento. Quell’Etna nel torace. Quella domanda: così strana e vera. Così ingiusta.

Simone Massara è nato a Messina, e tra Sicilia e Calabria ha trascorso gran parte del suo tempo. Adesso passeggia a Roma, dove studia anche Filologia moderna.
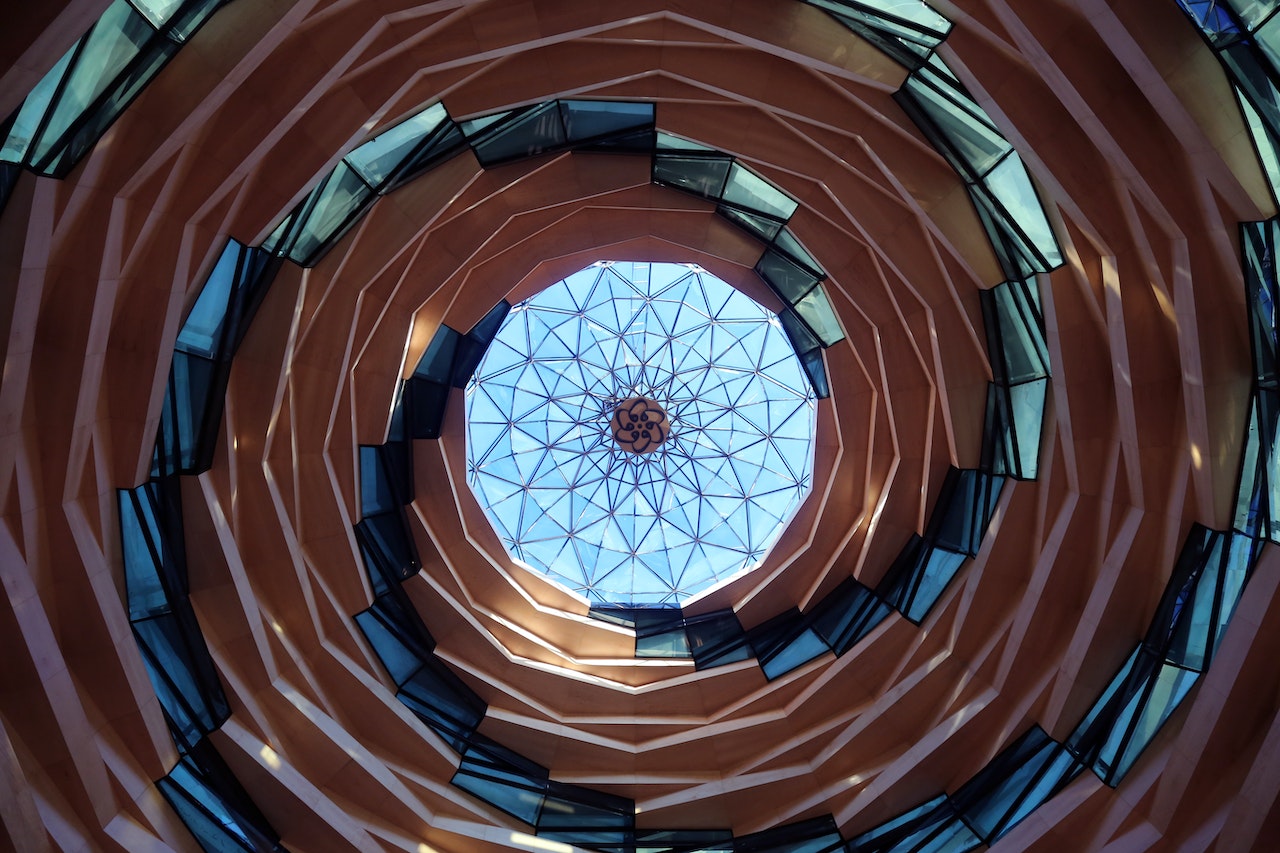
g e g²
Un racconto di Rudi Capra
Numero di battute: 2116
Tra i casi più interessanti mi è capitata G., una paziente di cinquantasette anni, avvocato. Venne da me in tacchi alti e tailleur di Armani, si sdraiò e disse: «Tutto è cominciato al funerale di R., mio marito, con cui ero sposata da ventitré anni. Lì notai una donna col mio stesso vestito. Era strano perché R. me lo aveva portato da un viaggio a Parigi. YSL, inconfondibile. Pensai che fosse una coincidenza. Finché rividi la stessa donna in metropolitana con un Panama identico a quello che R. mi aveva portato da Cartagena.
Fu allora che mi rivolsi a un investigatore privato, che la mise grossomodo in questi termini: “Signora, suo marito ha una relazione extraconiugale da ventisei anni con la stessa donna, G²., insegnante di filosofia al liceo Galvani, nubile. Spesso lo raggiungeva in viaggio…”».
«Tutto è cominciato al funerale di R.,
mio marito.»
Parlando con me nelle sessioni, G. non riusciva a non considerare quei ventitré anni di matrimonio un lungo, spregevole inganno, e così metà della sua vita. Dopo un lungo silenzio suggerii che la guarigione di un caso del genere dipendeva da uno sforzo importante: dovevano cominciare una terapia di coppia, G. e G²., che affrontasse l’elaborazione del lutto e la natura sdoppiata, bifronte di quella relazione.
Con mia grande sorpresa, accettò. Tornò accompagnata da G². e la terapia durò quasi un anno. Concludemmo che R. aveva sempre amato la stessa donna, che però erano due persone diverse, che R. provava a riunire in un’unica figura facendo con entrambe le stesse esperienze, regalando loro gli stessi oggetti. Non dovevano sentirsi amate a metà, piuttosto gioire di avere un’altra persona con cui condividere la perdita di R. Nell’ultima seduta si abbracciarono.
Tempo dopo lessi sul giornale che G². si era uccisa. Cocktail di sonniferi. La polizia venne a parlare con me. Quella notte non riuscii a dormire. Guidai fino a casa di G. Suonai, ma non aprì. Al mattino chiamai i pompieri e la trovarono nella vasca, l’acqua rossa ancora tiepida.
Forse aveva bisogno di G². per tollerare la perdita di R. O forse aveva solo paura che G². lo incontrasse prima di lei in un posto in cui non poteva raggiungerlo.

Rudi Capra è ricercatore in filosofie dell’Asia orientale e critico cinematografico, attualmente a Torino. Ha diverse pubblicazioni all’attivo e due monografie, una sul pensiero interculturale e una sul cinema di Nicolas Winding Refn. Suoi saggi e racconti sono apparsi anche su L’Indiscreto, Risme, Singola, Digressioni, Le parole e le cose.

olaf
Un racconto di Andrea Ballotti
Numero di battute: 2498
E chissà dove avevano buttato Ida. Chissà se anche lei l’avevano riempita di botte. Chissà se ce l’aveva fatta resistere. Passando le dita sotto la guancia sentiva il sangue raggrumato anche se l’occhio, a tastarlo così, alla cieca, non pareva tanto gonfio. La maglia era fradicia di sudore e il caldo, poi, non faceva per niente bene alla sua tisi. Quando i campi si ingiallivano e le lucciole si moltiplicavano, sfilando nella notte, Remo bestemmiava più forte e sperava che l’autunno ricominciasse presto.
Provò a sdraiarsi, aiutandosi coi gomiti e con le mani aperte. Fuori dalla finestra i grilli cantavano e si vedevano un paio di stelle, inutili e sbrilluccicose. Senza motivo, gli tornò in mente il vecchio Donati della Cascina E’ Mulèn.
«Anche lui, dopotutto, credeva in qualcosa.»
Il Donati gli aveva detto che il grano era venuto su robusto e che il raccolto sarebbe stato grasso. Così gli aveva detto e non c’era motivo di dubitarne. Il Donati era un tipo preciso e quando si metteva sul portico a riprendere un po’ di fiato pareva uno che credeva sul serio alla falce che taglia la spiga e alle vacche che tirano l’aratro. Non era una cosa da poco. E poi, lui sì che aveva il cuore buono e quando lo vedeva arrivare lo salutava alzando il berretto di paglia e correva subito a casa a prendere il fiasco del lambrusco.
Schioccando la lingua si tirò su, appoggiandosi al muro con due colpi di tosse che rimbombarono nello sterno come dentro a un enorme pozzo vuoto. Almeno, gli avessero lasciato il pacchetto di Macedonia e l’accendino. Niente. Afa appiccicosa e buio tutto intorno. Immaginò, sorridendo, che anche del buio si fidasse il Donati. Chissà se credeva anche alla morte o si accontentava di aspettare e basta.
Lui, Remo Cecchi, nome di battaglia Olaf, credeva che uccidere fosse una cosa facile anche se, quando sedeva su un paracarro a guardare la campagna, si chiedeva se quella terra così piatta e asciutta meritasse tanto sangue scivolato dentro. Poi pensava alle schiene rotte dei contadini, ai figli perduti, alle madri infiacchite, e allora si sentiva più tranquillo e si addormentava senza tormentarsi troppo.
Anche lui, dopotutto, credeva in qualcosa. Credeva che la sua Glisenti 1910 non si inceppasse mai e credeva che quel porco fascista di Leonida se l’era meritate quelle due pallottole sparate a bruciapelo in pieno petto. Buttò indietro la testa e immaginò che con un po’ di fortuna l’avrebbero fucilato il giorno dopo e avrebbero lasciato il corpo sul terrapieno, al sole di quell’ultima schifosa estate.
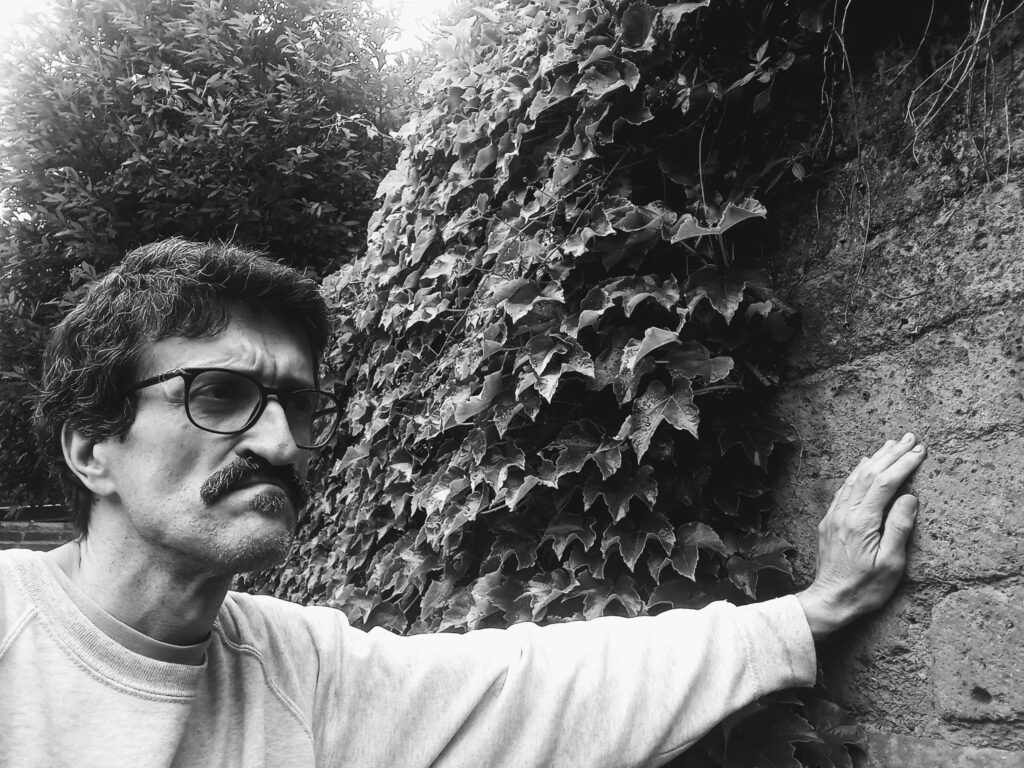
Andrea Ballotti è nato a Siena cinquantun anni fa. Laureato in Filosofia con un master in Letteratura e Editori, continua a vivere nella città del Palio. Ha una compagna, una figlia di quattro anni e una di quindici mesi. Ha praticato alpinismo per più di vent’anni. Come sport estremi, adesso, si dedica al disordine casalingo e al lancio del pannolino nell’indifferenziata.


Commenti recenti